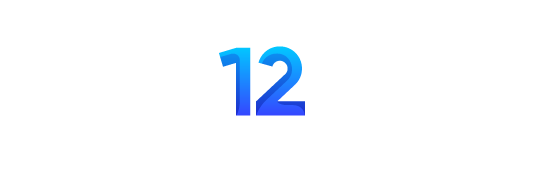I giovani d’oggi sarebbero disposti a morire per la libertà? Probabilmente no, per due motivi: perché non hanno ideali e perché non sanno cosa significhi non averla, la libertà. Questa una delle riflessioni stimolate dall’interessante e partecipata conferenza (presenti, tra gli altri, il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri e l’assessore alla Cultura del Comune di Piacenza Jonathan Papamarenghi e il consigliere comunale Antonio Levoni) che si è tenuta all’Associazione dei liberali piacentini Luigi Einaudi: un incontro per ricordare Jan Palach a cinquant’anni dal suo tragico gesto contro l’occupazione sovietica della Cecoslovacchia, che soffocò nel sangue la Primavera di Praga (nel gennaio del 1968 Dubcek venne eletto segretario del Partito comunista cecoslovacco e iniziò un periodo di tentato riformismo represso dall’intervento dei tank russi).
 Dopo Ferdinando Bergamaschi che aveva trattato settimana scorsa della figura di Solzenicyn, un altro giovane – Gianmarco Maiavacca, presentato dal presidente dell’Associazione Antonino Coppolino – ha rievocato un altro personaggio che ha lottato contro le atrocità del comunismo e proprio per questo è stato maltrattato dalla storia, per troppi anni raccontata a senso unico. «Come liberali – ha sostenuto il relatore – non dobbiamo tacere su cose non dette a livello nazionale. Non c’è solo l’Olocausto ma anche l’altra faccia della medaglia, il regime sovietico. Abbiamo allora il dovere di far presente che c’è un’altra storia, un’altra verità».
Dopo Ferdinando Bergamaschi che aveva trattato settimana scorsa della figura di Solzenicyn, un altro giovane – Gianmarco Maiavacca, presentato dal presidente dell’Associazione Antonino Coppolino – ha rievocato un altro personaggio che ha lottato contro le atrocità del comunismo e proprio per questo è stato maltrattato dalla storia, per troppi anni raccontata a senso unico. «Come liberali – ha sostenuto il relatore – non dobbiamo tacere su cose non dette a livello nazionale. Non c’è solo l’Olocausto ma anche l’altra faccia della medaglia, il regime sovietico. Abbiamo allora il dovere di far presente che c’è un’altra storia, un’altra verità».
L’avv. Maiavacca ha sottolineato come anche oggi Palach rappresenti «un simbolo di dignità e libertà per i popoli», rilevando che «per lungo tempo si è evitato, in Italia, di commemorarlo per non creare imbarazzo al Pci».
Ma chi era Jan Palach? «Uno studente di filosofia e lettere a Praga – ha ricordato Gianmarco Maiavacca -, nato nel 1948 da un padre anticomunista che gli trasmise la passione per la storia, la letteratura e gli insegnò l’importanza della coerenza morale. Durante la sua breve vita abbracciò tutte le riforme della Primavera di Praga». Grande fu la sua delusione per il ritorno del regime, ancor più repressivo di prima e accettato passivamente. Il 16 gennaio del 1969 il tragico gesto che fermò la storia: Palach si diede fuoco, non ancora 21enne, in piazza San Venceslao davanti ai carri armati sovietici per risvegliare il suo Paese dalla rassegnazione per l’occupazione. Morì tre giorni dopo. «Non fu un suicidio come vollero far credere in un primo tempo – ha spiegato l’oratore – ma un gesto di protesta, premeditato, contro il regime sovietico e contro la mancanza di voglia di sviluppo della sua Patria.
Un gesto che non fu vano: la caduta del muro di Berlino, vent’anni dopo, lo dimostra». Nel compiere il suo gesto estremo Palach fu lucido, proteggendo dal fuoco i suoi appunti e articoli che ripose in una borsa a tracolla che affidò a un tranviere che provò a soccorrerlo: “Non pensare a me – gli disse – prendi la borsa con i miei documenti e lasciami morire per la libertà: tutti devono sapere perché ho fatto questo”.
In quella borsa c’era una lettera di Palach, distribuita ai presenti: “Poiché i nostri popoli sono sull’orlo della disperazione e della rassegnazione, abbiamo deciso di esprimere la nostra protesta e di scuotere la coscienza del popolo. Il nostro gruppo è costituito da volontari, pronti a bruciarsi per la nostra causa. Poiché ho avuto l’onore di estrarre il numero 1, è mio diritto scrivere la prima lettera ed essere la prima torcia umana. Noi esigiamo l’abolizione della censura. Se le nostre richieste non saranno esaudite entro cinque giorni, il 21 gennaio 1969, e se il nostro popolo non darà un sostegno sufficiente a quelle richieste, con uno sciopero generale e illimitato, una nuova torcia s’infiammerà”. Palach non fu l’unico a darsi fuoco in nome della libertà.
Prima di lui Ryszard Slwiec a Varsavia, l’8 settembre 1968 e Vasyl Makuch a Kiev, il 5 novembre 1968; dopo di lui furono altre dieci i dissidenti dell’Est che diventarono torce umane. «Al suo funerale – ha proseguito l’avv. Maiavacca – parteciparono 600mila persone e Praga fu per un giorno in mano agli studenti: il potere della volontà di tutti per cambiare il corso della storia; una cosa che servirebbe anche oggi. Fu una pagina indimenticabile, eppure volutamente dimenticata. Palach – ha ribadito il relatore – morì per la sua nazione, per difenderne i confini dai carri armati. E i carri armati di oggi sono le procedure d’infrazione dell’Unione europea».
Gianmarco Maiavacca ha concluso la sua brillante trattazione citando una significativa frase: “Onore a Jan Palach, simbolo vivente, e morente, di un amore bruciante per la libertà e per la dignità dei popoli”.
Nel dibattito che è seguito, particolarmente significativa la testimonianza di Luigi Carini, che negli anni Sessanta frequentava i Paesi dell’Est, dove si era fatto tanti amici. «C’era in loro una fede per la patria e consideravano la morte quasi un dovere in nome della sua difesa – ha raccontato Carini – . Erano persone di cultura, parlavano 4-5 lingue e mi chiedevano di portagli i giornali perché non sapevano che cosa succedeva. La Polizia era ovunque. C’era un clima terribile, la gente spariva improvvisamente. Un giorno domandai come mai erano tutti vestiti di grigio. Se qualcuno si veste con colori sgargianti, mi fu risposto, viene subito segnalato perché considerato uno spirito ribelle».